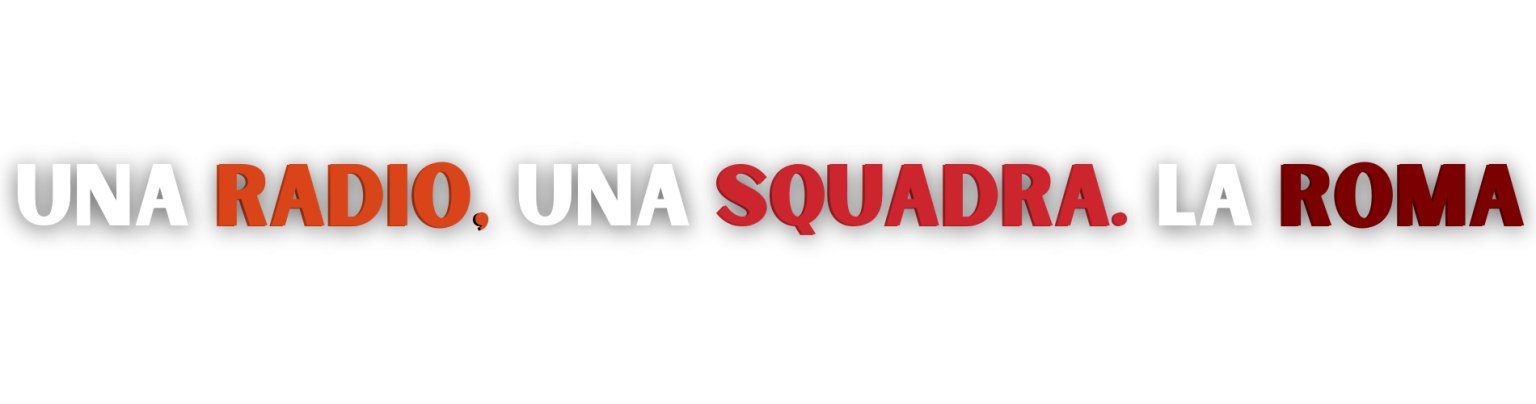Quando Daniele De Rossi, ha ridotto il calcio a un “regolamento di merda”, non ha cercato lo slogan, né la scena. Era semplicemente molto incazzato per qualcosa che non digerisce, l’ennesimo scempio. Ma nel suo essere molto incazzato ha detto una cosa che molti pensano da tempo e che quasi nessuno dice pubblicamente. La differenza è tutta lì.
La reazione a catena che ne è seguita lo dimostra, e in un epoca che brucia notizie alla velocità dello scroll di un reel, il suo sfogo è rimasto nell’aria come un fallout. Allenatori di primo piano, addetti ai lavori, voci autorevoli del sistema, speaker radiofonici, firme della carta stampata. Tutti anche a distanza di giorni, in sostanza, confermano che il problema esiste. Che non è una boutade. Che non è un capriccio di giornata. Tutti, senza mezzi termini, hanno dato l’idea di sentirsi rappresentati da quelle parole.
Dietro di loro un popolo di “innamorati stanchi”, immischiati in una relazione tossica con il calcio: come quando si rimane con una donna per quello che era all’inizio e non per quello che è diventata, sperando sempre in quel picco di emozione che un tempo ti regalava.
De Rossi non ha aperto un dibattito. Ha tolto il coperchio. E una volta tolto, quello che c’era sotto è venuto fuori da solo. Un rigurgito molto più condiviso e unilaterale di quanto le istituzioni stesse probabilmente credevano.
Una crepa nel silenzio (spesso complice)
Il punto non è una norma, un protocollo o una singola interpretazione. Il punto è il calcio che si è costruito negli ultimi anni: uno sport sempre più spezzettato, sempre meno fisico, sempre meno riconoscibile.
Un calcio in cui il contatto è diventato sospetto, in cui ogni scivolata viene sezionata al microscopio, in cui anche un semplice contrasto genera minuti di attesa e discussione. Un calcio finito spesso in balìa di decisioni figlie di quattro, cinque teste diverse: arbitro, VAR, AVAR, sala di controllo, interpretazioni soggettive che si sovrappongono invece di chiarire.
Il risultato è un gioco confuso, incoerente, incapace di dare certezze nemmeno sulle situazioni più elementari. Stessi episodi valutati in modo opposto da una partita all’altra, rigori concessi e tolti senza una logica percepibile, falli di mano che cambiano significato ogni stagione.
Dentro questo contesto conviene spesso stare zitti, abbassare la testa, limitarsi alle frasi neutre. Non perché si sia d’accordo, o si avalli uno scempio, ma perché esporsi ha un costo. De Rossi quel costo sembra disposto a pagarlo ed è forse qui che si sta disegnando il vero profilo del suo futuro.
Non tanto quello del grande stratega destinato a dominare le panchine per vent’anni (l’etichetta del “predestinato” forse lo ha nauseato di più di quella di “capitan futuro”) , quanto quello di una figura che lascia una traccia diversa. Non legata ai trofei, ma al modo di stare dentro questo mondo.
Non è un tratto scoperto ora. De Rossi è sempre stato così: diretto, lineare, poco incline ai compromessi di facciata. Quello che ti entrava in scivolata a forbice, non quello che temporeggiava. Non indossa maschere. Dice quello che pensa, anche quando non conviene.
Cresciuto controvento
Non è un caso che venga da una carriera costruita interamente nella Roma. Una squadra che, storicamente, ha vissuto spesso il ruolo di antagonista che quello di favorita. Una piazza che ha maturato, nel tempo, la sensazione di dover lottare anche contro il contesto, non solo contro l’avversario. Una piazza di tanto sangue amaro e poco oro.
De Rossi si è abituato presto a stare dalla parte “scomoda”. A subire meccanismi, a non dare nulla per scontato. Come se si fosse allenato per vent’anni non solo sul campo, ma anche mentalmente. Come se avesse sviluppato, allo stesso tempo, una naturale riluttanza verso il sistema e gli anticorpi necessari per fronteggiarlo.
All’epoca, più giovane, reagiva in campo e davanti ai microfoni, ma era lo stesso di oggi. Rappresentava la Roma, veniva considerato di parte: già minava il sistema, senza però essere preso troppo sul serio da chi quel sistema all’epoca lo abbracciava e ne raccoglieva i golosi frutti. Passava la narrativa del “rosicone”, ma non è un caso se al centro della Curva Sud, tra tanti grandi capitani, la bandiera più grande sia dedicata proprio a lui.
Oggi porta quella formazione dentro la panchina. Non fa battaglie ideologiche, non si propone come paladino. Semplicemente dice quello che vede. Ed è proprio questo che rende le sue parole più fastidiose: non sembrano studiate, non sembrano strategiche. Sono frutto di carisma, “cohones”, e anni di abitudine a stare controvento.
In un calcio sempre più pieno di comunicazione controllata, dichiarazioni filtrate, risposte uguali a se stesse, uno che parla in modo diretto e quasi elementare, diventa automaticamente una voce netta, fuori dal coro, rivoluzionaria. Trasversale e non di parte, non a protezione del proprio orticello, ma dell’intero sistema calcio.
Ecco. Forse De Rossi non diventerà l’allenatore simbolo di una nuova era tattica. Ma può diventare qualcosa di diverso.
Se il suo destino fosse quello di spronare chi ama questo sport, che lo viva all’interno o all’esterno del sistema, a reagire? Di provare a riportarlo a quello che per un secolo ha fatto innamorare generazioni? Di farsi portavoce, anche inconsapevole, di un moviemento che non ne può più di stravolgimenti, esultanze strozzate, revisioni, mani che aumentano volumi, mani che stringono altre mani in palazzi lontani dal prato verde.
Per De Rossi il calcio resta due zaini, un prato e un pallone che rotola: un gioco semplice, che lo ha reso trasversale e popolare proprio perché dall’ultima categoria alla Serie A il concetto di base è sempre stato quello. E in quello scenario l’arbitro è un corollario: l’esultanza è immediata e senza ripensamenti, le decisioni si prendono all’istante e il fallo, per essere fallo, deve fare male all’avversario.
Riportare questo nel calcio, anche fosse di poco rispetto alla deriva odierna: non sarebbe un’impresa forse degna di dieci campionati?